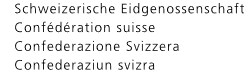«La Svizzera ha bisogno di essere un po’ più simile a Friburgo»
Friburgo, 01.08.2025 — Allocuzione del consigliere federale Martin Pfister, capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in occasione dei festeggiamenti del 1° agosto, Friburgo, 1° agosto 2025.
Fa fede la versione orale
Stimato signor presidente del Consiglio di Stato (Jean-François Steiert),
Stimato signor sindaco (Thierry Steiert),
Stimati membri del Municipio,
Stimati membri del Consiglio comunale,
Stimata rettrice dell’Università di Friburgo (Katharina Fromm),
Stimati abitanti della Città di Friburgo e dei suoi dintorni,
Talvolta si vorrebbe essere po’ più simili a Friburgo
Vi ringrazio dell’invito. Per me venire a Friburgo non è un appuntamento obbligatorio legato alla mia funzione, ma un ritorno a casa.
Conosco bene Friburgo avendoci vissuto, studiato e lavorato per 12 anni. E se la mia vita fosse andata un po’ diversamente, probabilmente sarei rimasto a Friburgo. Perché qui mi sono sempre trovato molto bene. Da allora so che la città vecchia di stampo medievale, che potrebbe sembrare incline alla lentezza, trae in inganno. Friburgo è un microcosmo cosmopolita e talvolta un po’ peculiare. Qui sono di casa non solo il «Carnaval des Bolzes», ma anche una varietà sorprendente di personalità. La città ha dato i natali ad artisti come Jean Tinguely o Abbé Bovet, a importanti pedagogisti come Père Girard, a macellai ben noti e considerati delle vere e proprie icone come il Boucher Corpaato e a ristoratrici leggendarie come Marie-Rose Holenstein del Café du Gothard.
O a numerosi giornalisti navigati, professori un po’ sbadati, influenti consiglieri federali e altre personalità interessanti, tanto che a volte si vorrebbe che il resto della Svizzera fosse un po' più simile a Friburgo.
Pur avendo vissuto a Friburgo per un certo periodo, purtroppo non sono riuscito né a diventare un artista, né un pilota, nonostante nell’ultimo periodo vivessi in Route-Neuve, dove Jo Siffert aveva fatto l’apprendistato di meccanico d’automobili nell’autofficina dell’epoca. Ma ho amato la città di Friburgo e ho imparato il francese, o almeno quanto basta per essere eletto in Consiglio federale. In questo senso, care friburghesi le cari friburghesi, vi devo molto.
Per me è quindi un grande onore che mi abbiate invitato come oratore oggi. Sono molto lieto di poter trascorrere la mia prima Festa nazionale in veste di consigliere federale insieme a voi.
In questa occasione vorrei condividere con voi non solo i miei ricordi personali di Friburgo, ma anche alcune riflessioni che mi stanno particolarmente a cuore in qualità di membro del Governo nazionale:
- quali sono gli elementi che ci accomunano in Svizzera – a maggior ragione in tempi difficili;
- perché non dobbiamo dare per scontato il valore della nostra sicurezza;
- e cosa possiamo fare tutti insieme per fare in modo che il nostro Paese rimanga anche in futuro un luogo improntato alla fiducia, alla libertà e alla condivisione.
Stiamo vivendo un periodo carico di tensioni
Il 1° agosto è un giorno festivo, ma è allo stesso tempo un giorno di riflessione e gratitudine. Soprattutto in un periodo in cui i valori che diamo per scontati, come la pace, la libertà e la sicurezza sono sempre più messi in discussione.
Stiamo osservando
- come certezze acquisite stiano svanendo,
- come fatti diventino alternativi
- e come la polarizzazione sia in aumento.
Il Röstigraben «n’existe pas»
Per molto tempo il nostro Paese è stato risparmiato dai conflitti che affliggono il mondo.
Da generazioni le guerre hanno avuto luogo solo all’estero. La nostra aspettativa di vita è in continuo aumento. E nell’indice dei Paesi più felici la Svizzera si colloca stabilmente ai primi posti.
Il panorama politico è altrettanto stabile. La Svizzera è un’entità complessa, multilingue, peculiare. E ovviamente anche in questo Paese relativamente piccolo i contrasti sono causa di tensioni. Però di norma in Svizzera le linee di interesse e di conflitto non corrispondono ai confini linguistici, cantonali e religiosi.
Anche il tanto famigerato Röstigraben si sta rivelando essere un cliché. Altrimenti la Città di Friburgo non avrebbe invitato, proprio in occasione della Festa nazionale, un consigliere federale della Svizzera tedesca il cui francese, come si sente, è un po’ arrugginito dai tempi dell’università e del servizio militare nella Svizzera romanda.
Cosa tiene unito il nostro Paese
Il panorama politico in Svizzera non si è sviluppato da solo. È stato costruito passo dopo passo dai nostri antenati, molto spesso anche con lotte aspre. Le forze che tengono unite questo Paese sono rimaste stabili fino a oggi.
Mi riferisco a:
- istituzioni affidabili che vigilano su coloro a cui abbiamo affidato temporaneamente il potere;
- politici che ascoltano i cittadini e prendono sul serio le loro richieste;
- una società che crea benessere grazie all’impegno senza per questo dimenticare chi è più debole;
- una cultura politica in cui il compromesso non è una parola offensiva, bensì una soluzione con cui tutti possono convivere;
in particolare però, la Svizzera viene mantenuta coesa da persone che fanno molto più del loro dovere:
- i politici di milizia negli oltre 2000 comuni di questo Paese;
- i cittadini che nel loro tempo libero si impegnano in club sportivi, nei pompieri, nelle associazioni di quartiere, nell’esercito o nella protezione civile;
- i parenti e i volontari che accompagnano e assistono persone malate, anziane e bisognose.
Tutti loro meritano la nostra gratitudine. Sono proprio questi volontari e queste persone che fanno funzionare il nostro Paese.
Nel suo discorso di fine mandato, il presidente tedesco Gauck ha affermato che la democrazia non è una società politica di vendita per corrispondenza tenuta a soddisfare nel modo più completo possibile le aspettative e le richieste della sua clientela. Reputo che avesse ragione.
Questo vale in particolare per una democrazia diretta come quella svizzera che vive di cittadini critici che determinano in prima persona il futuro del loro Paese, forniscono un contributo attivo e non lasciano l’incombenza a un uomo o una donna apparentemente forti.
A fine maggio a Blatten abbiamo potuto constatare che la maggioranza della popolazione di questo Paese non considera la Svizzera un fornitore di servizi, bensì una comunità. Dopo la frana dagli effetti catastrofici che ha seppellito un intero villaggio, sono intervenuti non solo l’Esercito svizzero e la protezione civile, ma anche un gran numero di volontari. La solidarietà della popolazione svizzera nei confronti degli abitanti della Lötschental è ancora oggi eccezionale.
Non viviamo più nel migliore dei mondi possibili
Possiamo senz’altro essere orgogliosi di questa coesione e della storia del nostro Stato federale. Tuttavia, non basta più celebrare questa giornata con la consueta dignità e autosufficienza tipica del nostro Paese. Non possiamo fingere che tutto vada bene.
La Svizzera non è un’isola. Facciamo parte del mondo. E il mondo non solo è fragile, ma anche permeabile. Tutto scorre: merci, denaro, informazioni. Ormai il mondo è talmente interconnesso che un evento che si verifica in un angolo remoto del globo finisce sempre per ripercuotersi anche sul resto del mondo. L’Europa e la Svizzera non sono più un porto sicuro in cui possiamo aumentare e distribuire indisturbati il nostro benessere.
Le conseguenze dei cambiamenti climatici, delle pandemie, ma anche delle guerre in Medio Oriente, in Ucraina o in Sudan non si fermano ai nostri confini.
È chiaro che la fine della guerra fredda non ha segnato la fine della storia, ma solo una breve pausa.
L’idea che vivevamo «nel migliore dei mondi possibili» oggigiorno purtroppo si rivela essere una pericolosa illusione. Non ci sono carri armati lungo il lago di Costanza. Ed è piuttosto improbabile che ci saranno in un prossimo futuro. Però il mondo è diventato meno sicuro, e questo non cambierà a breve termine.
Anzi: la situazione odierna in Europa ricorda in maniera inquietante gli anni ‘30 del secolo scorso: anche quella fu un’epoca caratterizzata da profonde crisi a livello economico, sociale e politico. In seguito alla crisi economica mondiale numerose persone persero la fiducia nei partiti e nelle istituzioni consolidate. Ciò spianò la strada a movimenti di stampo autoritario, a populismi nazionalisti e a una radicalizzazione del dibattito politico.
Oggi assistiamo a sviluppi simili: in molti Paesi i partiti storici si indeboliscono, mentre quelli di protesta raccolgono sempre più consensi. Anche la disponibilità a mettere in discussione i valori democratici fondamentali è in aumento, così come la sfiducia nei confronti dei media e della scienza.
All’epoca questi sviluppi portarono alla nascita di dittature in numerosi Paesi e infine alla guerra.
La Svizzera non è un’isola
Dal passato possiamo trarre vari insegnamenti, ad esempio che il futuro non è semplicemente una continuazione del passato. Anche se ho appena menzionato le similitudini con gli anni ‘30, rimane una differenza fondamentale: oggi l’Europa è composta da democrazie consolidate e nella società c’è una consapevolezza ben maggiore dei pericoli legati all’autoritarismo.
La storia, quindi, può fungere da monito, ma non come destino ineluttabile. Però anche la coscienza politica non è una condizione rigida e immutabile. È malleabile e costantemente sottoposta a pressioni.
Viviamo in un’epoca in cui realtà e reality show sono spesso difficili da distinguere. Non è sempre semplice sottrarsi al flusso di banalità e presunte verità sui social media.
Ma la politica non è un circo e non è un palcoscenico da cui lanciare titoli ad effetto. Per citare il sociologo Max Weber, la politica è un mestiere che richiede responsabilità: fatto di tenacia, pazienza, serietà e dedizione per il bene comune.
In democrazia il lavoro politico affonda le sue radici nei fatti. Le cittadine e i cittadini decidono sulla base dei fatti, anche se non sempre sono piacevoli. Perché in una democrazia la verità non è un’imposizione forzata, ma una forma di rispetto.
Dobbiamo adeguarci alle nuove minacce
Ciò include uno sguardo realistico sul mondo. Dopo decenni caratterizzati da un ordine mondiale apparentemente sicuro, in cui abbiamo beneficiato di un dividendo della pace, all’improvviso dobbiamo tornare a fare i conti con gli scenari più cupi. La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, in particolare, ha conferito a questo compito una nuova urgenza. In qualità di capo del DDPS è mio dovere impegnarmi a favore della sicurezza della popolazione svizzera.
In questo contesto la protezione del nostro Paese grazie a un esercito capace di difendersi e la difesa da ciberattacchi rivolti contro le nostre infrastrutture critiche, come la fornitura di energia elettrica o le reti di telefonia mobile, assumono un’importanza fondamentale.
In quanto Paese situato nel cuore dell’Europa dipendiamo dalle buone relazioni con i Paesi confinanti. La salvaguardia della nostra libertà è possibile solo attraverso la cooperazione, non agendo da soli. Chi desidera rafforzare la capacità di difesa della Svizzera deve quindi rafforzare anche la cooperazione internazionale.
Difendiamo i nostri valori
Non si tratta solo di difendere il nostro territorio. Si tratta anche di difendere i nostri valori: la libertà; la democrazia; lo Stato di diritto.
Sono conquiste che caratterizzano la nostra convivenza. E alle quali possiamo guardare con un certo orgoglio a maggior ragione il 1° agosto.
Però per difendere questi valori i beni d’armamento non bastano. Negli anni ‘30 del secolo scorso il Consiglio federale dell’epoca sviluppò il concetto di «difesa spirituale». In questo modo la Svizzera lanciò un chiaro segnale contro il razzismo, il nazionalismo etnico e i regimi autoritari, contrapponendo i suoi valori fondamentali.
Più tardi però, per paura di infiltrazioni comuniste, questa idea si trasformò in una sorta di «mentalità da bunker spirituale»; si tratta di una mentalità tipica della guerra fredda di cui non ho nostalgia.
Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è qualcosa di diverso: non isolamento, ma forza interiore. Ciò che invece auguro a tutti noi in questi tempi difficili è una sorta di resistenza spirituale. Una resilienza mentale contro:
- gli incendiari politici;
- le chiacchiere digitali;
- e la ristrettezza di vedute.
Oppure per dirla in altre parole:
«Essere un po’ più simili a Friburgo».
È un compito che richiede impegno.
Da parte mia.
Da parte vostra.
Da parte di tutti noi.
Vi ringrazio.